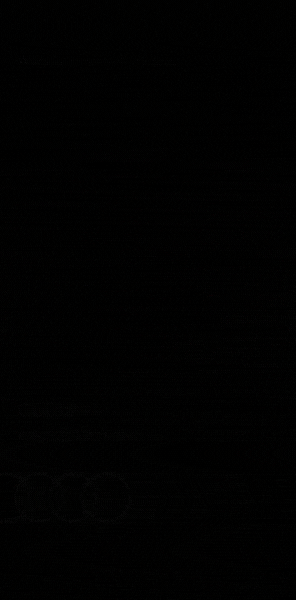di Monica Prati – Legno, terra e paglia. Materiali semplici che uniti alla tecnica danno vita ad un edificio. Ma com’è possibile? Ce lo spiega Roberto Zuccari, apicoltore dagli anni ’80.
Come é nata l’idea del laboratorio in bio-edilizia?
«L’idea è nata da una considerazione che mi hanno portato a fare le api. Esse trovano tutto quello di cui hanno bisogno per la sopravvivenza in un territorio circoscritto di circa tre chilometri. Dato che dovevo costruire un ambiente dove conservare il frutto prezioso del loro lavoro in un posto ricco di storia e dal paesaggio interessante come Fronzola, mi sono chiesto: perché non costruire in modo da non impattare nell’ambiente e nello stesso tempo avere una dimensione di lavoro e di vita diversa da quelle che di solito si vede nelle aziende?
Queste di solito sono improntate soprattutto ad un discorso tecnologico e meno attente ad altri temi. Così ho iniziato a pensare ai materiali, ai mattoni, che ho visto crescere nei campi vicino casa in cui ci seminavano il triticale. Ho deciso di usare la tecnica di costruzione con presse di paglia, che poi sono state intonacate con la terra cruda unita ad altri materiali come fibre vegetali e coccio pesto (per un discorso di umidità). Quindi due materiali li avevo già a portata di mano, come le api che trovano acqua, polline, nettare, tutto quello che serve per l’esistenza; a questi poi è stato unito il legno. Il risultato è stata una costruzione a tutti gli effetti uguale ad un edificio.
Con il vantaggio di un’ottima coibentazione per cui il miele si conserva benissimo perché non ci sono sbalzi di temperatura, è fresco d’estate e caldo d’inverno, senza bisogno di riscaldamento. La temperatura è sempre costante e quindi c’è anche un risparmio energetico notevole. Da questo progetto, che ho chiamato “ad un volo d’ape” è nata l’idea di costruire con la paglia e che potrebbe benissimo essere un’alternativa, in un ambiente come il Casentino, ricco dei materiali che servono, alle classiche costruzioni. Da un punto di vista agricolo, mi domando perché un agricoltore che fa le sue culture non può utilizzare la paglia per fare un capannone dove mettere ad esempio gli attrezzi. Perché non costruire aziende con questo sistema?
Devo dire che il risparmio non c’è per quanto riguarda l’intonacatura che è una fase delicata e lunga e che richiede tanto tempo e personale competente e specializzato per questo tipo di costruzioni (proveniente dal nord Italia) ma il risparmio c’è per l’aspetto energetico, per i materiali riciclabili, la resistenza al fuoco e eventi sismici, insonorizzazione e altri benefici. A mio parere per il Casentino, questa tecnica di costruzione potrebbe essere percorribile, in alternativa ad altri metodi».
Quanto tempo ha richiesto la costruzione del laboratorio? Perché non costruire anche le abitazioni con questa tecnica?
«È stato necessario molto tempo per la solita burocrazia, ma questo avviene anche per costruzioni convenzionali; nella prima fase abbiamo lavorato praticamente in autocostruzione, col conseguente tributo all’inesperienza, ma ci siamo divertiti anche molto, non è stato certo un cantiere tradizionale! Abbiamo lavorato in pratica tutta l’estate, perché il lavoro è stato diviso in tre fasi: prima si fa un intonaco con un tipo di impasto, si fa asciugare, dopo un mese si fa il secondo e poi il terzo. Invece, per quanto riguarda gli altri materiali, come il canapulo, abbiamo dovuto farlo arrivare dal nord Italia. Per le travi ho utilizzato il lamellare proveniente da Grosseto, mentre per il soffitto ho usato il legno di abete delle nostre foreste.
Questa tecnica di costruzione è conosciuta e praticata in tutta Europa. In nord Italia ad esempio, ci sono aziende che realizzano con appositi macchinari presse da costruzione in misura standard che poi, dopo un periodo in magazzino (per togliere umidità), vendono alle imprese costruttrici.
In Casentino forse per ignoranza, forse per mancanza di proposte in tale direzione da parte degli addetti ai lavori, è ancora poco sviluppata. Purtroppo da noi non si può costruire senza una struttura portante (una specie di gabbia) perché la paglia non è considerata materiale da costruzione, quindi occorre realizzare una specie di gabbia in legno, per poter procedere ad un lavoro di tamponatura.
Nel resto d’Europa questo non è previsto, inoltre da noi non è un materiale autoctono, non è ancora incluso nell’elenco dei Materiali da costruzione e allora una domanda retorica sorge spontanea il legno usato nella bio-edilizia è autoctono? No, viene dai paesi dell’est a voi le conclusioni. Occorre un cambiamento di mentalità, la volontà anche politica di intraprendere queste nuove possibilità, potrebbe essere una risorsa locale e si potrebbero creare un nuovi posti di lavoro per i giovani».
L’attività di apicoltura ne ha beneficiato?
«Certo, la paglia rende calda e accogliente la struttura e il miele è custodito con cura e con il minimo impatto sull’ambiente. La mia è un’attività di “apicoltura nomade” certificata bio, cioè costituita da una serie di alveari che sposto in tutta la Toscana, dalla maremma alla Val D’Orcia, per produrre miele che va da quello all’erica a quello di castagno, abete, millefiori.
Le zone di produzione sono accomunate tutte dal territorio simile a quello del Casentino, cioè poco contaminate dal punto di vista ambientale e ciò è molto importante sia per le api che per il produttore e incide sul prodotto che viene offerto al consumatore. Stiamo vivendo una realtà particolare in apicoltura: non si può prescindere dal fattore ambiente, che per le api è fondamentale e ce ne stiamo rendendo conto perché noi produttori siamo presi tra il martello e l’incudine. Il martello è rappresentato dai cambiamenti climatici e l’incudine dall’utilizzo sconsiderato di pesticidi.
Dobbiamo armarci di buona volontà, di fermezza come abbiamo sempre fatto a partire dagli anni ottanta con il problema degli acari parassiti. Sono stati gli apicoltori in prima persona che si sono organizzati per arginare il problema. Anche attualmente penso che dipenderà molto dagli apicoltori risolvere il problema dei pesticidi. Purtroppo, senza un’agricoltura consapevole dei danni causati dai prodotti chimici, andremo incontro ad un destino di tracollo del settore apicoltura.
Questo è un grosso problema, perché le sostanze date ai vigneti, ai frutteti quando arrivano a contatto con le api possono causare nella peggiore delle ipotesi la morte dell’animale, per assunzione diretta della sostanza, che torna all’alveare per avvisare le altre api del pericolo e poi spira e, nella migliore delle ipotesi, la sostanza agisce in modo subdolo, li per li non ci si accorge del tracollo poi con il passare dei mesi, le api spariscono perché hanno immagazzinato quel polline inquinato. E qui si innesta un problema più grande, perché l’indebolimento delle api porta conseguenze negative per la biodiversità e la conservazione della natura.
Naturalmente diversi agricoltori hanno optato per un’agricoltura biologica, perché hanno capito il gioco che poi è quello delle multinazionali. Altri, non so se per mancanza di consapevolezza o per scelta, hanno sempre usato prodotti chimici e continuano a farlo».
(tratto da CASENTINO2000 | n. 324 | Novembre 2020)