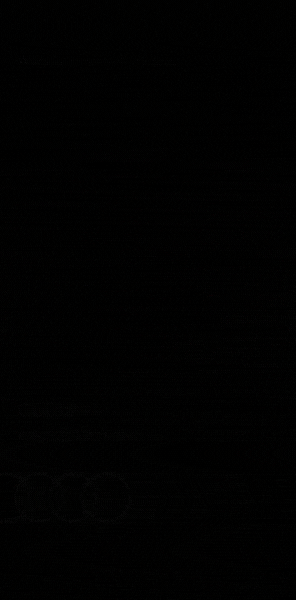di Lara Vannini – La cucina è un’arte ma potremmo anche dire che essa è nutrizione, condivisione ed anche memoria storica. La cucina come scienza era già nota al famoso gastronomo romagnolo Pellegrino Artusi che già nella seconda metà dell’800 fu autore di un best-seller (diremmo oggi!), di fama internazionale: “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, le cui ricette furono messe a punto raccogliendo tradizioni culinarie di tutta Italia. Artusi riuscì a includere nella sua raccolta cibi gustosi e ricchi di storia che, nel caso della cultura gastronomica contadina, erano costituiti da ingredienti con un preciso significato simbolico.
L’uovo ad esempio simbolo della Pasqua e desiderio ambito per ogni bambino, esisteva come tradizione anche nella cultura contadina, ma non di cioccolata come saremmo portati a pensare oggi. Il significato dell’uovo come simbolo della vita e del mistero, si perde nella notte dei tempi ed è presente in molte religioni e culture dell’antichità. Dagli antichi Egizi alla tradizione cristiana fino ad arrivare ai giorni nostri, l’uovo è sempre stato simbolo di vita, rinascita e Resurrezione, la vita terrena che non finiva con la morte, ma andava oltre e dava speranza agli uomini.
La tradizione contadina voleva infatti che il giorno di Pasqua si portassero le uova sode in chiesa a farle benedire, per poi mangiarle nell’abbondante colazione che sarebbe stata apparecchiata dopo la messa. Le uova erano simbolo di Resurrezione, ma anche energetiche e il loro ritorno sulla tavola dopo l’astinenza della Quaresima preannunciava la rinascita primaverile. Infatti in Primavera gli uccelli facevano il nido per deporre le uova e quindi appena se ne avvistava uno, era certo che la stagione fredda fosse agli sgoccioli.
A conferma di come le uova fossero doni graditi e pregiati anche in altri periodi dell’anno possiamo ricordare che, a Carnevale per esempio, si regalavano le uova agli uomini che andavano ad intrattenere i paesani con la fisarmonica oppure, ringraziando di un servigio, si poteva sempre regalare una coppia d’uova. Banalmente era più facile regalare le uova in Primavera anziché in altri periodi dell’anno perché era anche il periodo in cui le galline ne deponevano in maggior quantità.
Il Pan di Ramerino o rosmarino, era un altro cibo considerato dai contadini “pane Santo di devozione”. È un dolce tipico della Toscana e poteva già essere preparato dal Giovedì Santo in preparazione alla Pasqua. Veniva usato il rosmarino perché oltre ad essere una pianta facilmente reperibile, era una pianta officinale dai molteplici significati simbolici. Sinonimo di immortalità, con il suo forte e caratteristico profumo, era noto per le proprietà antisettiche e tranquillizzanti. Nella tradizione popolare veniva già usato sotto il cuscino come scacciapensieri. Dal punto di vista religioso la leggenda narra che durante la funga in Egitto della Sacra Famiglia, il mantello della Madonna scivolasse su una pianta di rosmarino rendendo i fiori dell’arbusto di color azzurro come il manto di Maria.
In questa carrellata di prelibatezze “sacre” come non citare il popolarissimo Ciambellone pasquale con il Vin Santo (liquore usato anche nelle celebrazioni eucaristiche), una vera gioia per gli occhi e per il palato.
Per preparare il Ciambellone venivano usate molte uova perché il periodo precedente di Quaresima erano giorni di astinenza anche dal cibo e quindi l’uovo poteva essere un integratore naturale a buon mercato e alla portata di tutti. L’uovo era un alimento eccezionale che poteva essere bevuto anche da fresco senza troppi problemi o come rinforzino unito alla minestra.
La Panina originaria proprio del Casentino, è un pane semi-dolce molto saporito con uvetta, spezie, strutto e a volte un pizzico di zafferano. Pur avendo un sapore dolce, non disdiceva con un companatico salato come una fetta di prosciutto. Ancora oggi nei ristoranti che preparano il pranzo di Pasqua è molto comune trovare un antipasto di uova benedette, panina, qualche crostino e salumi locali.
Sulla tavola apparecchiata per la colazione non potevano poi mancare gli zuccherini o berlingozzi, dalla tipica forma a ciambellina fatti di farina, uova, olio, a volte zucchero a cui poteva essere aggiunto dei semi di anice. Dolcetto antichissimo già presente nel Rinascimento, veniva a volte chiamato “berlingozzo” forse da “berlingare” ovvero divertirsi a tavola, godere di buone pietanze.
La vera regina dei dolci restava, però, sempre lei “la Pasta reale”, oggi conosciuta come torta Margherita, un dolce che si ricorda anche per il suo procedimento e il tipico rumore di mestoli sbattuti durante la sua preparazione. Le massaie infatti dovevano montare le chiare a mano e poi unirle ai tuorli avendo cura di non far “smontare” il composto perché sarebbe stato questo segreto a rendere la pasta soffice e maestosa al punto giusto.
(trtto da CASENTINO2000 | n. 317 | Aprile 2020)