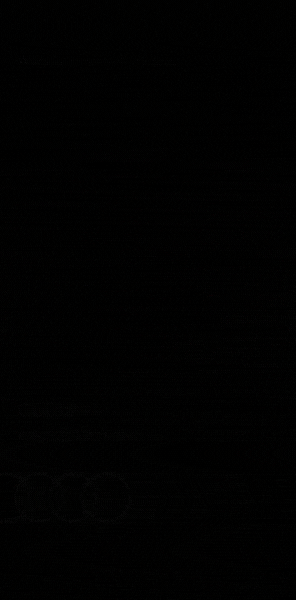di Enrico Ciabatti – Dopo le nostre Alpi ed Appennini (Era terziaria) nel Periodo del Miocene (22 milioni di anni fa) si solleva l’Anello oroidrografico Casentinese, formando una conca o depressione di alcune decine di metri al di sotto dell’attuale livello del terreno e rocciosa, con pareti scoscese, ma le aree erbose e le piante tropicali d’alto fusto nutrono mammiferi e scimmie antropomorfe. Il clima è caldo.
L’orogenesi o modificazione della crosta terrestre causata da fenomeni endogeni (del sottosuolo) è realtà ancor oggi in atto. Vedi “L’origine delle montagne” a p. 34 del tascabile (10×15) illustrato “Geologia” di G.Pinna, A. Martello Ed., MI, 1971. All’inizio del Pliocene (5 mil. di anni fa) l’Atlantico sfonda Gibilterra e tutte le zone costiere della nostra Penisola (non Sardegna e Corsica) sono sommerse dal mare, che raggiunge la massima estensione (cfr.nel 2786 T. Pievani e M. Varotto, op. cit. nel n°336). Il Mediterraneo è arricchito nell’ittiofauna mentre in pianura scompaiono molti mammiferi, ma non nelle zone montane. Il clima è tropicale ed arrivano da noi i primi ominidi africani,che sostituiranno i Neanderthal.
Durante il Pliocene il nostro Bacino lacustre comincia a riempirsi di acqua, detriti e limo con progressive colmate alluvionali che riempiono le fossette tettoniche ed aree depresse mentre si innalza il fondale vallivo tra Stia e Bibbiena. Dilavamenti meteorici e correlati fenomeni erosivi pedemontani a carattere torrentizio stanno progressivamente sagomando i contorni collinari che iniziano ad apparire e mutare. Si formano calanchi fluviali, scoscese ripe lacustri (Arcena Ripa), scarpate collinari, lunghi terrazzamenti pedemontani solcati da insenature vallive e tra essi il più importante ed esteso a me pare bene il Promontorio di Camenza, (n°337), stante la buona altezza del Baralla, con i suoi 7×2 Km. in linea d’aria dall’alpe (m.1204) alla riva sx d’Arno (oggi m.300 ca. slm). Nel Pleistocene (2 mil. di anni fa), un clima temperato precede le 4 fasi glaciali e durante l’ultima (35000 anni fa) si estingue l’Homo di Neanderthal.
Al Pliocene superiore appartiene il Lago villafranchiano del Casentino di cui parla C. Starnazzi e poi GIG in op. cit. nel n°337. Tra gli altri bacini lacustri e coevi il nostro è il n° 4 nel disegno dell’Italia Centrale, asse FI-AR-Orte, lungo il primo corso di Arno e Tevere (Etruria antica). Questo lago è da me detto di Arcena perché uno specchio lacustre prende il nome dal suo punto di sbarramento, qui tra S. Andrea ed il Poggio del Fallito. Non trascuro di citare il Dr. Amedeo Bigazzi, con me Socio della “Petrarca” dal 1984, e rammento che uno specchio d’acqua dolce può essere “contenuto” (non ostacolato!) da barriere naturali (nel caso in questione oramai illeggibili!) o da seriori opere di regimazione (tecnologia idraulica e industriale) che devono sempre assecondare (non stravolgere!) la vocazione ambientale-economica del posto. In pianura il contenimento idraulico di un alveo fluviale deve prevedere “casse di espansione” trasversali all’impeto della corrente in aree non edificabili (cfr. la nostrana alluvione del 1966, l’ultima di una recente serie).
Già Augusto Sacco nel suo “Scienze Naturali e Fisica”, Ed. Lattes, TO, 1948, ammoniva (p.121) che “i boschi sono regolatori (senza spese!) delle acque meteoriche ed anche del clima e della salubrità dell’aria (p.122), dunque una prevenzione (a costo zero!) contro inquinamento, polveri sottili e pestilenze. Ad A.Sacco fa eco L. Rombai in “Casentino”, Polistampa, FI, 2012, ricordando le Riforme Lorenesi e Carlo Siemoni (pp. 56-66). Il contenimento idraulico longitudinale lungo corsi d’acqua corrente prevede invece argini viabili poco elevati, con fori di drenaggio o volte per le vie di deflusso meteorico in alveo, da lasciare a cielo aperto meglio che in cloaca coperta, evitando rimpozzi e sottopassi alluvionabili.
Altri interventi di utilizzo di una risorsa d’acqua corrente sono costituiti (o previsti) da chiuse, cateratte, saracinesche, pescaie, triplice recinzione confluente (Socana e Bibbiena), quadrilateri (a valle del Garda), canalizzazioni primarie o secondarie ad uso irriguo, ponti in legno (effimeri, non troppo costosi),guadi stagionali (in ragione di evoluzioni idrografiche), abbeverate (allevamenti), acquacoltura, veicolazione di merci o di legnami (foderi), porti fluviali (Poppi, Bibbiena, ecc.), berignoli per molitura (grani e castagne, ecc.), gualchiere per industria tessile o follatura e feltratura di lane (la Lana Casentino di Stia) o per industrie conciarie per la gualcatura dei pellami, ferriere a maglio idraulico e non dimentichiamo a Bibbiena la Torre del Tannino, ecc.. fino alle moderne centrali idroelettriche, la cui alternativa è l’energia solare o eolica.
Il Promontorio di Camenza somiglia ad un gigantesco “pesce martello” con la coda sul Baralla ed il ventre che va da Gressa (l’antico molino bibbienese è quello di Gressa, sulla riva sx dell’Archiano) a Poggio Mercatale, l’antico Emporio di Bibbiena con la sua Porta della Gabella (oggi dei Fabbri). La testa di questo metaforico gigante ittico guarda strategicamente con l’occhio sx alla foce del Vessa (dal lat. “vexo”!) e con l’occhio dx vigila attentamente la foce dell’Archiano (dal lat: “arceo”!). Dalle terrazze di S. Andrea, da quella “piazzolina” del Tarlati e da quella “fondaccina” di S. Lorenzo si dominano l’Imbuto del Pollino (da “polleo”: far pressione) o Confluens Aequor e la Gola di Arcena (Arcenae Fauces). Il livello del lago omonimo, aumentato da continue colmate, tracimò appunto rovinosamente (C. Starnazzi, op. cit) sfondando la Chiusa del Pollino (Pollens Aequor) oltrepassando l’insellatura di Bibbiena (tra il Fosso di Arcena e La Nave) ed incidendo le Gole del Groppino (tra il Rassina e “Casaliclum”), di San Mamante e di Calbenzano (sotto il “templum” di Lorenzano) per trovare a Giovi il suo sbocco. Dopo la tracimazione, il Lago di Arcena, meno profondo e più basso di livello, divenne qua e là un pescoso stagno, tra le pigre anse dell’Arno (in un letto largo centinaia di metri), poi una verde e boscosa palude (tapiri ed ‘Elephas antiquus, ecc.) ed infine una depressa torbiera fino a trasformarsi nelle fertili chiane a vocazione agricola della Bibbiena di oggi. “Biblena Terra” (Vitali) sta per “Boschiva Terra” e cioè appunto “passumena (da “pando”) ferax terra” (terra solatia e perciò fertile!). Niente il nostrano toponimo ha a che fare col verbo “bibo” (Vitali) o col gentilizio “Vipena” (Nocentini) se Bibbiena preesisteva di gran lunga agli Etruschi, da noi di passaggio.
Con altra metafora, poiché “panta rei”, questo lago che nasce, cresce e muore (come Civita di Bagnoregio) è un “vaso” prima vuoto, poi colmo e tracimante ed infine di nuovo vuoto d’acqua ma ricco di frutti (il Cyperus aveva qui rizoma commestibile!), messi e allevamenti. C. Starnazzi alle pp. 65-66 di ”Preistoria” con riferimento a questo lago parla di radici, tronchi, foglie e piante d’alto fusto e non solo suffruticose: tra le altissime sequoie e l’umile vite il Cyperus era alto fino a 6 metri.
Vedi anche il botanico B. Peyronel e l’egittologo E. Scamuzzi alle voci “ciperacee” e “papiro” in Diz UTET di P. Fedele: la “Cyperus Papyrus Liliiflorens” (o “Niliaca Papyrus” di Marziale XIII,1,3) prosperava qui da noi, in regime climatico caldo umido subtropicale, nel Pleistocene.
I Greci non accolsero il nome egizio di questa pianta edule ed usata per costruire imbarcazioni, cesti, reti, gomene, sandali, ecc. Erodoto la chiamò “biblos” e Teofrasto “pàpyrus”: Vedi anche Lucano (omissis). Da Plinio il Vecchio in poi queste due voci sono usate con il significato limitante (non preciso) di “libro” e “foglio”. •••
VEDI. L. Lazzeri: La geologia (pp. 257-263) in Il Casentino Octavo F. Cantini Ed. FI, 1995. A. Pedone: La nascita del bacino (toscano) in Atti del Convegno (dic. 2017) dell’Acc. Petrarca di AR.
FOTO IN ALTO. Reperto esposto al Museo Archeologico del Casentino “Piero Albertoni” di Bibbiena (www.arcamuseocasentino.it).
NELLA FOTO SOTTO. Da Preistoria (1988) di Carlo Starnazzi la figura 8 – I grandi laghi villafranchiani ove il n. 4 è il lago del Casentino.