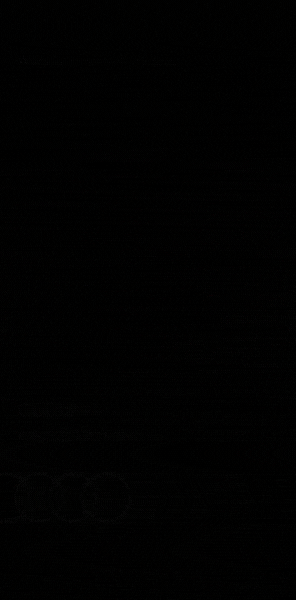di Mauro Meschini – Quando leggerete questo articolo speriamo che l’uscita dal tunnel in cui ci ha rinchiuso questa epidemia possa essere almeno un po’ più vicina. Non possiamo dire molto di più rispetto a questo e, d’altra parte, se c’è una cosa di cui possiamo essere certi in questa drammatica vicenda è che non abbiamo certezze. Nessuno, anche solo la notte dello scorso 31 dicembre, avrebbe potuto pensare di vedere dopo qualche settimana praticamente sconvolta la propria vita e totalmente cambiata la “normalità” a cui da sempre eravamo abituati. Il fatto poi di parlare di qualcosa che non ha risparmiato nessun Paese sulla Terra ci fa sentire ancora più impotenti e in una condizione in cui sicuramente è difficile vivere: quella di non poter decidere liberamente cosa fare e non poter fare progetti per un futuro più o meno vicino.
La nostra generazione, quella nata negli anni del boom economico, non ha mai dovuto affrontare emergenze di questo genere. Qualcuno la paragona ad una guerra, almeno perché come la guerra ha, purtroppo, causato tante, troppe vittime. Ma forse questo accostamento è improprio, anche perché le armi e gli eserciti di cui abbiamo bisogno in questa situazione sono ben diversi da quelli che caratterizzano da sempre le guerre o i conflitti di vario genere.
In questa emergenza in tutto il mondo si sta mettendo in campo quanto di meglio l’umanità abbia potuto creare, facendo contemporaneamente affidamento ai valori e alle emozioni più belle che sia in grado di esprimere.
Nonostante il dramma delle tante persone che hanno perduto la vita e l’immenso dolore provocato ai loro cari; nonostante i sacrifici e la fatica che in tanti hanno dovuto sopportare negli ospedali e per far funzionare la complicata catena di assistenza e cura che è stato necessario mettere in campo; nonostante le difficoltà che, soprattutto gli anziani, hanno dovuto affrontare, magari da soli e senza un aiuto o sostegno vicino in queste lunghe settimane. Nonostante tutto questo, dovremmo davvero fare uno sforzo e tenere ben a mente quello che abbiamo visto e provato in questo lungo periodo di tempo in cui la nostra vita è apparsa come sospesa nel vuoto e piena di punti interrogativi. Lo dovremmo fare perché questo potrebbe aiutarci a continuare in un modo migliore il nostro viaggio su questo pianeta, pianeta che, come tanti esempi in giro per il mondo hanno dimostrato, può benissimo fare a meno di noi e delle nostre attività, anzi di questo sarebbe ben lieto.
Dopo le tante discussioni e i tentativi di ridicolizzare i messaggi lanciati da Greta Thumberg e dai giovani che hanno partecipato alle mobilitazioni dei “Friday for future”, dovrebbero far riflettere le dichiarazioni di alcuni scienziati che hanno parlato di un possibile legame tra diffusione del virus e livello elevato di inquinamento. Da questo punto di vista poi verificare come il blocco delle attività umane abbia portato a sensibili diminuzioni di gas inquinanti in pianura Padana e in altre zone, oppure livelli di limpidezza delle acque del mare che ormai non si rilevavano da tempo, anche a Venezia, dovrebbe far comprendere a tutti, e definitivamente, che è necessario cambiare drasticamente abitudini, modalità di produzione, livelli di consumo di energia e patrimonio naturale.
Per quanto riguarda poi l’aspetto che in queste settimane è stato, naturalmente, più ricordato vogliamo sperare che tutti abbiano compreso cosa significa vivere in un Paese in cui, anche se con oggettivi limiti, esiste un sistema sanitario pubblico.
Anche l’ultimo della classe avrebbe dovuto capirlo da tempo ma, purtroppo, abbiamo visto nel recente passato in alcune regioni italiane, come la Lombardia o la Toscana, forze politiche, sulla carta di diverso orientamento, perseguire in maniera categorica lo smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata. L’emergenza che stiamo affrontando in queste settimane ha scoperchiato la pentola della pessima gestione delle politiche sanitarie e, per esempio, vediamo come quello che è accaduto in Lombardia sia già oggetto di attente valutazione per l’enormità delle difficoltà e dei lutti che in quella Regione si sono registrati.
Ma, per rimanere più vicino a noi, non possiamo che essere almeno sorpresi, in questa emergenza, per quello che viene detto in Toscana. Il Governatore Enrico Rossi in un’intervista a Rainews24 del 9 aprile ha proposto il suo pensiero partendo dall’assunzione di 2.000 operatori sanitari «… 1600 tra infermieri e Operatori Socio Sanitari e 400 medici… La verità è che si è troppo risparmiato, anche negli ospedali, dove il personale aveva dei tetti di spesa assurdi… il personale è stato demotivato la sanità privata sicuramente è andata avanti in questo periodo… tutti segnali di un cedimento pesantissimo…».
Sono gli stessi argomenti che nel 2015 avevano portato tanti toscani a sostenere il referendum abrogativo regionale della legge sanitaria voluta proprio da Enrico Rossi e dal PD che, tra l’atro, prevedeva un taglio di personale di circa 2.000 persone, l’accorpamento delle Asl e l’accentramento delle decisioni, la penalizzazione e chiusura di tanti servizi nei territori; qui in Casentino non dobbiamo e possiamo dimenticare il Punto Nascita e il graduale smantellamento dell’ospedale di Bibbiena sostenuto senza battere ciglio da tutti i sindaci passati e presenti. Se ricordate su quel referendum non fu possibile arrivare al voto perché il Consiglio regionale, guidato da Eugenio Giani, nel mese di dicembre dello stesso 2015 fece di tutto, anche con sedute notturne, per approvare una nuova legge sanitaria che impedì ai toscani di esprimersi liberamente.
Ascoltare queste “sagge” argomentazioni da chi è stato uno degli artefici dei tagli alla sanità pubblica rende evidente che da quello che sta accadendo non si è imparato niente. La politica si appresta a riprendere le stesse abitudini, con dichiarazioni e comizi a reti unificate, e mancate assunzioni di responsabilità e impegni veri finalizzati al bene comune. Questo vale naturalmente per tutti, non possiamo infatti non essere almeno irritati dal clima di campagna elettorale permanente che continuano a riproporre Matteo Salvini o Giorgia Meloni, soprattutto se ricordiamo che fino a non molto tempo fa il primo aveva le stesse posizioni negazioniste sul contagio del Premier inglese Boris Johnson, che per fortuna è riuscito a superare la malattia che lo aveva colpito.
Dovremmo prenderci davvero il tempo per ricordare, per riflettere, per avere sempre in mente quello che è accaduto perché, inevitabilmente, il nostro presente è sempre figlio del passato. Le scelte fatte producono oggi i loro effetti e, in questa emergenza, alcune di quelle scelte hanno prodotto effetti devastanti.
Abbiamo letto, ascoltato e visto in questo lungo “periodo sospeso” tante testimonianze e la cronaca, praticamente in diretta, di quello che ha rappresentato fare i conti con una minaccia invisibile e pericolosa. Ci ha costretto a cambiare la quotidianità, le abitudini, ha tagliato legami e interrotto le storie delle nostre vite. Ci ha messo di fronte ad una realtà nuova, probabilmente non piacevole, ma che ci può aiutare a comprendere meglio sia quello che eravamo sia quello che potremmo essere.
Non è scontato che verranno fatte le scelte migliori e vedere ancora oggi l’importanza che si attribuisce alla ripresa del campionato di Seria A di calcio, al PIL, alle dispute tra maggioranze e opposizioni, al calo del prezzo del petrolio, senza che nessuno provi anche solo a pensare se esistono altri aspetti che dovremmo prendere in considerazione per provare a uscire al meglio da un momento di crisi così pesante, rende evidente quanto sia ancora la strada da costruire. Ci sono state e ci sono voci che possono essere prese da esempio per costruire un “altro” futuro.
Il 18 Marzo del 1968 Robert Kennedy, tre mesi prima di essere ucciso, pronunciava, presso l’università del Kansas, un discorso nel quale evidenziava, tra l’altro: «…Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta…».
In queste settimane Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006, economista e banchiere bengalese ideatore e realizzatore del microcredito moderno, ha proposto su Repubblica un altro interessante contributo che affida a tutti noi la scelta del futuro che vogliamo. «In questo momento tutto il mondo deve trovare una risposta a un grande interrogativo. Non si tratta di come far ripartire l’economia perché, per fortuna, sappiamo già farlo. Le esperienze vissute in passato ci hanno aiutato a mettere a punto una terapia generica per ridare vita all’economia. No, il grande interrogativo a cui dobbiamo dare risposta è un altro: riportiamo il mondo nella situazione nella quale si trovava prima del coronavirus o lo ridisegniamo daccapo? La decisione spetta soltanto a noi. Inutile dire che, prima del Coronavirus, il mondo non ci andava bene. Fino a quando tutti i titoli dei giornali non sono stati dedicati interamente al coronavirus, ovunque si gridava a gran voce annunciando le terribili calamità che stavano per accadere. Contavamo letteralmente i giorni che mancavano a quando l’intero pianeta sarebbe diventato inabitabile per la catastrofe climatica. Parlavamo di quanto fosse grave la minaccia di una disoccupazione di massa provocata dall’intelligenza artificiale, e in che modo la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi stesse raggiungendo un livello deflagrante. Ci rammentavamo di continuo a vicenda che questo decennio è l’ultimo a nostra disposizione. Al termine di esso, infatti, tutti i nostri sforzi porteranno a risultati soltanto parziali, inadeguati a salvare il nostro pianeta.Dovremmo tornare a quel mondo? A noi la scelta. All’improvviso il coronavirus ha cambiato radicalmente il contesto delle cose e i dati spiccioli. Ha spalancato davanti ai nostri occhi possibilità temerarie che non erano mai state prese in considerazione in precedenza. All’improvviso, eccoci di fronte a una tabula rasa. Possiamo andare in qualsiasi direzione vorremo. Che incredibile libertà di scelta!…»
(tratto da CASENTINO2000 | n. 318 | Maggio 2020)