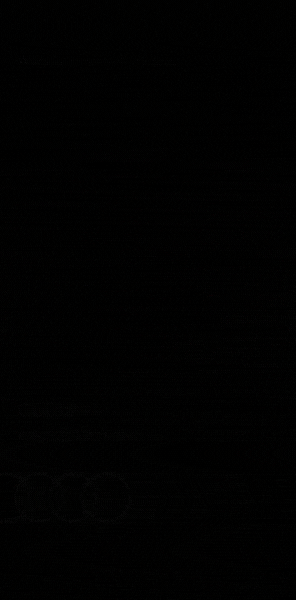di Lara Vannini – Biondo, prezioso e possibilmente abbondante, il grano ha rappresentato l’oro vegetale dei nostri avi casentinesi. A luglio con “la falce in pugno” intere famiglie rurali, si apprestavano alla mietitura e alla successiva battitura delle messi. Oggi, soprattutto nei piccoli appezzamenti, troviamo qua e là campi incolti, resti di terrazzamenti, selciati e mulattiere dismesse che ci raccontano di un tempo passato fatto di fatica e sudore della fronte. In Casentino come in altri luoghi, il paesaggio è radicalmente mutato nel tempo, sono cambiate le abitudini di vita e gli insediamenti abitativi. È proprio per questo che fonti orali, racconti dei nonni e antiche testimonianze fotografiche, possono aiutarci a riscoprire il nostro territorio e a vedere con gli occhi dell’immaginazione i nostri avi in azione, chini sui campi assolati durante la stagione estiva.
A luglio prendeva avvio la mietitura del grano poi il contadino si dedicava alla battitura, entrambe le attività erano molto lunghe e dispendiose di energia. Il contadino, per portare a termine il gravoso lavoro per il grano, necessitava di intere settimane e coinvolgeva un gran numero di persone, ognuna delle quali era addetta ad una mansione specifica. La battitura era uno dei momenti più importanti del calendario contadino, sia per l’approvvigionamento di un bene di prima necessità come il grano e quindi la farina, che per la complessità del lavoro e il sacrificio che ne sarebbe comportato.
La mietitura veniva fatta in “proprio” e a mano se il podere era di limitate dimensioni, altrimenti ci voleva un aiuto esterno e volendo, per chi poteva permetterselo, delle mietitrici meccaniche. In città e nelle grandi aziende già negli anni ’40 del 900 veniva fatto uso della mietitrice meccanica ma nelle campagne la diffusione avvenne molti anni dopo.
È importante ricordare che i contadini casentinesi ebbero un ruolo di primo piano nella mietitura del grano, tanto da spostarsi in altre campagne toscane come in Maremma per prestare la propria manovalanza a qualche proprietario terriero. Spesso i contadini lavoravano a cottimo e quindi dovevano faticare molto se volevano guadagnare qualcosa in più a fine giornata. Se da una parte le ore di sole erano tante e quindi utili per lavorare, dall’altra il giorno sembrava non finire mai per la fatica della mietitura e il calore dei raggi solari. Nella famiglia contadina non veniva risparmiato nessuno: mietevano uomini e donne e quest’ultime si occupavano anche del desinare. Cotti dal sole, spezzati dalla fatica, i contadini stavano tutto il giorno nei campi assolati, coperti di pezzole e cappelli di paglia. I “mannelli” ovvero i mucchi di steli tagliati con la falce messoria, venivano via via depositati per terra in file ordinate. Più “mannelli” legati andavano a formare i “covoni” di grano che poi potevano essere messi per verticale nella forma a capanna che tutti conosciamo. Sicuramente ognuno di noi avrà sentito più di una volta questi termini, ma forse mai si sarà soffermato a comprenderne il significato e il legame che avevano con la mietitura. Proprio per il problema del caldo sia la mietitura che la battitura iniziavano di buon mattino: alle 4 ci si alzava per andare sul campo. A colazione le donne preparavano la polenta di mais. Alle 8 avveniva generalmente la seconda colazione con pane, affettato e formaggio il tutto preparato amorevolmente dalle donne di casa. I recipienti preferiti per portare la colazione erano i cestini di vimini che spesso venivano intrecciati dagli uomini, nelle rigide sere inverali durante il riposo dei campi. Il lavoro proseguiva senza sosta fino a mezzogiorno quando le campane della Chiesa avvertivano che era ora di pranzare.
Per gli uomini poteva seguire un breve riposino prima di ritornare al lavoro. Importante era evitare le ore centrali, le più calde della giornata.
La Trebbiatura poteva essere fatta con il “correggiato” o per i più fortunati, con la macchina trebbiatrice. Il correggiato percuoteva il grano disteso sull’aia fino a che il chicco non fosse uscito dalla spiga dopo di che esso sarebbe stato faticosamente diviso dalla “pula” in attesa di essere vagliato successivamente.
Il pranzo della battitura se veniva fatto nell’aia, era una gran festa. I ragazzi servivano il vino e venivano preparati arrosti di carne, pollo, coniglio e ocio. L’Ocio non mancava mai sulla tavola della trebbiatura, il suo lungo collo veniva svuotato e riempito di uno speciale ripieno che lo rendeva saporito e molto gustoso se fatto al tegame. Così come in altre circostanze di vita comunitaria, i ragazzi più giovani non vedevano l’ora di conoscere delle belle ragazze mentre gli uomini già sposati ne approfittavano per schiacciare un pisolino magari all’ombra di un grande albero.
(tratto da CASENTINO2000 | n. 320 | Luglio 2020)