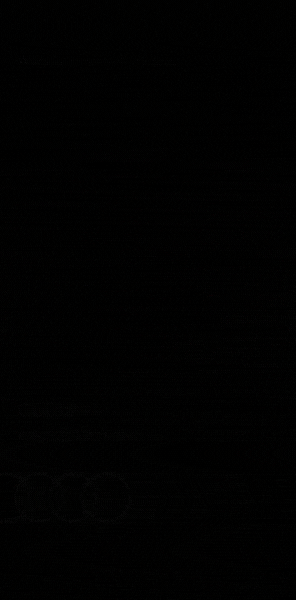di Mauro Meschini – Il passaggio del Covid-19 e tutto quello che ne è seguito potrebbero lasciare segni profondi. Non parliamo in questo caso solo delle conseguenze economiche, sicuramente rilevantissime e ancora non del tutto quantificabili, ma vorremmo allargare l’attenzione su altri effetti che potrebbero portare a vedere mutazioni e cambiamenti radicali nell’organizzazione della vita sociale, produttiva, organizzativa dei singoli e delle comunità. La forzata clausura ha reso possibili esperienze e situazioni a cui probabilmente nessuno aveva anche solo pensato in tempi di “normalità”. Si sono visti gli animali selvatici girare indisturbati per qualche città o paese. Le acque dei fiumi in più casi sono diventate limpide come nessuno a memoria d’uomo poteva ricordare. Ci siamo accorti che alcuni possono tranquillamente lavorare da casa, mentre purtroppo altri hanno avuto la dura conferma di quanto sia precario un lavoro, soprattutto se non è garantito da un contratto. Si è visto poi che questo viscido virus sembra abbia trovato terreno più fertile nelle zone dove ci sono livelli di inquinamento più alti e il Casentino, con il suo per fortuna bassissimo numero di contagiati e ricoverati, sembra essere lì a dare una conferma a questa ipotesi.
Insomma, questo tempo sospeso che ha lasciato, tra l’altro, anche tanto spazio vuoto da riempire, di cose da raccontare ne ha avute e forse è per questo che in queste settimane si sono rincorsi interventi e accavallate interviste che hanno aperto il dibattito che ha riportato alla ribalta la centralità dei piccoli Borghi storici.
Abbiamo viaggiato un po’ nella rete e abbiamo trovato quattro interventi che rispetto a questo tema presentano approcci anche molto diversi. Vogliamo proporli in sintesi come introduzione di una riflessione che poi vorremmo fare puntando l’attenzione sul nostro territorio.
L’architetto Stefano Boeri in un’intervista a Repubblica ha dichiarato: «… Tutti hanno capito che il verde è un tema importante. Ma in Inghilterra già si prevede una grande spinta verso l’abbandono delle zone più densamente popolate. Succederà anche in Italia, chi ha una seconda casa ci si trasferirà – abbiamo ormai capito le potenzialità del lavoro a distanza – o ci passerà periodi più lunghi. Ma questo processo andrà governato. Servirebbe quindi una campagna per facilitare la dispersione, e anche una ritrazione dell’urbano, per lasciare spazio ad altre specie viventi…».
Poi ha puntato l’attenzione sulla presenza di tanti Borghi da salvare. «Io penso ad un grande progetto nazionale: ci sono 5.800 centri sotto i 5.000 abitanti e 2.300 sono in stato di abbandono. Se le 14 aree metropolitane adottassero questi centri, con vantaggi fiscali e incentivi…».
Sulle proposte di re-distribuzione abitativa è intervenuto anche Fausto Anderlini, direttore del Centro Demoscopico Metropolitano e del Settore programmazione della Provincia di Bologna, con un articolo pubblicato sulla Community online Nuova Atlantide – l’isola che non c’è.
«… hanno riproposto quello che è avvenuto in questi decenni, a partire dai ’70, cioè esattamente da mezzo secolo a questa parte. Il decentramento residenziale, la cosiddetta suburbanizzazione… Un processo per il quale la popolazione residente di tutti i più grandi poli urbani si è re-distribuita sul territorio. Nelle aree metropolitane l’addensamento è dovuto oggi alle popolazioni presenti, non a quelle residenti. Un addensamento funzionale dovuto non tanto alle industrie ma alla concentrazione delle attività terziarie. Il distacco fra residenza e luogo di lavoro interessa tutte le popolazioni, ma soprattutto quelle terziarie impiegatizie. Le quali abitano nelle galassie suburbane e vanno a lavorare in centro».
Dopo questa netta presa di distanza ecco la proposta.
«L’unico modo di riformare questo modello (che comporta costi ambientali crescenti) non è perciò di diluire le concentrazioni ma semmai di introdurre rotture nella continuità degli insediamenti, con l’aggiunta di una redistribuzione delle funzioni che minimizzi gli spostamenti fisici. Lo smart working è una illusione. Non solo perché non è generalizzabile, ma anche perché indesiderabile. Inoltre lascerebbe intatto il sistema insediativo, mentre larga parte degli spostamenti non sono legati al solo lavoro… Dunque, semmai, sistemi urbani compatti, concentrati e ben distanziati, lasciando lo spazio per vaste porzioni di territorio ri-naturalizzato. E in senso forte, ben oltre la “forma parco”. Vere e proprie aree selvatiche. Se è vero che una delle ragioni dei crescenti contagi virali è anche l’erosione sino ai minimi termini delle zone selvatiche popolate dal regno animale».
Anche Francesco Chiodelli, docente di geografia economica e politica all’Università di Torino, su Il Manifesto propone alcune critiche alla proposta di abbandonare le città per i piccoli centri.
«Sono almeno due le debolezze di tale idea. La prima è relativa al presupposto su cui si basa: quello che, al tempo della pandemia (considerata tra l’altro come destinata a durare svariati anni, forse decenni, quando tutto ciò non è affatto certo), la densità residenziale è un problema in sé. Su tale presupposto sollevo alcuni elementi di dubbio – alimentati anche dalla constatazione che, per ora, le aree più colpite dal Covid-19 in Italia non sono solo e tanto aree a elevata densità residenziale, ma anche zone, al contrario, di profonda dispersione (come la provincia di Bergamo)… Ma anche se il presupposto del carattere pernicioso della densità residenziale fosse vero, la proposta della «ritrazione dall’urbano» rimane poco convincente. Sembra infatti nutrita da un romanticismo tipico di chi i piccoli comuni li ha vissuti solo da turista».
E tanto per spiegare cosa si intende, poco più avanti nell’articolo la realtà dei piccoli Borghi viene presentata in maniera molto concreta.
«Molti di questi ultimi sono paesini quasi inaccessibili, non necessariamente affascinanti dal punto di vista architettonico e spesso privi dei servizi pubblici essenziali; in cui, sovente, la connessione internet è decisamente zoppicante, con buona pace dello smart working… Sono luoghi che si sono progressivamente depopolati non per un capriccio, ma perché qui la vita è dura: i servizi lontani, le opportunità lavorative quasi nulle, le relazioni sociali asfittiche. Per andare a scuola, all’ospedale o a prendere il treno devi farti un’ora di auto su strade tortuose e difficilmente percorribili nella stagione invernale».
Infine un altro contributo che entra molto più a fondo nel presentare la vita nei piccoli Borghi è quello di Sandro Bozzolo, documentarista e PhD in Migrazioni e Processi Interculturali all’Università di Genova, che sempre su Il Manifesto scrive.
«Ben venga, dunque, un serio dibattito circa il destino di uno stile esistenziale coltivato lungo i secoli, soprattutto in un’epoca, come quella attuale, che ha mostrato in maniera evidente l’inadeguatezza di quel che Pasolini definì «sviluppo senza progresso». Ciò che è stato malamente accantonato è un territorio quasi interamente terrazzato, addomesticato e reso abitabile, garantendo canoni di bellezza estetica e di sostenibilità il cui riflesso ha contribuito (e potrebbe continuare a farlo) a rimodellare un’intera economia e un’intera società. Si, tratta, in primo luogo, di un paradigma che intende la vita umana come un’esperienza il più possibile completa, fondata su un rapporto armonico tra l’essere umano e lo spazio circostante, tra lavoro manuale e azione intellettuale, in un prendersi cura del mondo che va oltre alla mera soddisfazione di saper produrre con le proprie mani parte di ciò che si consuma».
Se lo riterrete utile potrete ritrovare in rete i testi completi dei testi citati e in questo modo avrete la possibilità di approfondire meglio il tema, per quanto ci riguarda in questo confronto virtuale abbiamo trovato interessante l’intervento di Boeri perché ha lanciato una proposta, ma per quanto riguarda la realizzazione concreta crediamo che si possano trovare negli altri tre articoli spunti più condivisibili.
Il Casentino ci sembra proprio quella realtà presentata da Chiodelli, dove piano piano i paesi si stanno svuotando, dove il lavoro è un’utopia, dove hanno chiuso anche un ospedale e tagliano servizi fondamentali, dove spostarsi è un’odissea.
Ma è anche un luogo, come afferma Bozzolo, dove si possono ancora trovare le tracce di un sistema di vita fortemente in sintonia con il territorio e la natura, un luogo ricco di sapere sano e prezioso.
Se è così allora questo angolo di Toscana potrebbe avere le carte in regola per essere, parafrasando Anderlini, uno spazio montano autonomo dotato di servizi. Uno spazio in cui è presente un sistema economico e produttivo capace di rispondere alle necessità lavorative dei residenti. Uno spazio che valorizzi la tutela dell’ambiente e del territorio e che sia capace di presentare un’offerta turistica che si spalma su tutta la vallata con molte meno sagre e grandi eventi, che probabilmente saranno ancora soggetti a vincoli e limitazioni, e più luoghi e attività diffuse nelle singole realtà a favore di piccoli gruppi in maniera continuativa e per l’intero anno.
Piccolo è bello, in Casentino lo sappiamo bene, ma lo può essere davvero solo se a questo territorio viene permesso di vivere, se ai suoi abitanti viene permesso di avere un lavoro che non costringe a fare decine di chilometri ogni giorno, se spostarsi lungo le strade cessa di essere un pericolo, se avere una connessione internet non è più un problema, se viene garantita la presenza di un ospedale e dei servizi sanitari territoriali.
In questo momento in cui tutto appare precario e il futuro sembra sfuggire di mano dobbiamo fare di tutto per riprendercelo.
(tratto da CASENTINO2000 | n. 319 | Giugno 2020)