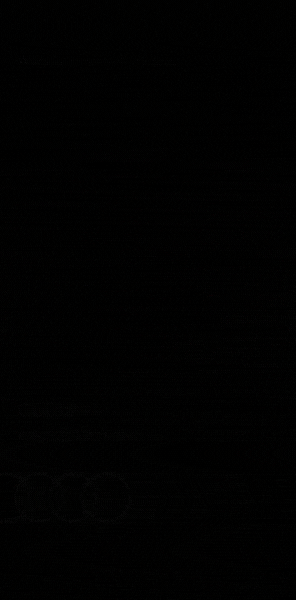di Fiorenzo Rossetti – Esiste un dibattito che tiene sempre più banco, ed è quello tra chi ama oltremisura l’ambiente naturale, vedendo nell’istituzione di Parchi un importante strumento di conservazione della biodiversità e occasione di rilancio di un’economia sostenibile e chi, invece, interpreta i Parchi come un grande ostacolo alla crescita economica e alle attività tradizionali, nonché un aggravamento burocratico fatto di regole e divieti.
Chi ha ragione?
Immaginiamo per un attimo se nel 1993 non fosse stato emanato il decreto che ha dato i natali al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: come sarebbe oggi il territorio di crinale tra Romagna e Toscana?
Il Parco Regionale del Crinale Romagnolo, area protetta antecedente l’istituzione del Parco nazionale, sarebbe forse ancora in vita e, nonostante alcune difficoltà di risorse e di politiche dettate dalle varie Giunte regionali dell’Emilia-Romagna, avrebbe svolto un egregio lavoro. Molto probabilmente sul versante Toscano non vi sarebbe alcuna area protetta e la caccia al cinghiale e cervo sarebbe in gran voga.
Le magnifiche foreste di faggio e abete non sarebbero oggi tanto conosciute e apprezzate per il loro valore e la loro bellezza, tanto da divenire patrimonio dell’umanità Unesco. Studi, monitoraggi, pubblicazioni sull’ambiente naturale del territorio si conterebbero sulle dita di una mano. Ben poche sarebbero state le azioni di pianificazione conservativa vocata allo sviluppo sostenibile. Sentieri, centri di informazione, didattica e fruizione ambientale non esisterebbero, almeno non nelle forme e dimensioni attuali. Le molteplici iniziative ed eventi che siamo oggi distrattamente abituati a vivere non ci sarebbero e l’impoverimento culturale sarebbe evidente. Il sostegno alle filiere economiche locali sarebbe merce rara; perse sarebbero le occasioni di rilancio economico, sociale e delle infrastrutture dei paesi del Parco. Ampie zone sarebbero state disboscate e piegate alla industria del legno, il potere del cemento e le pale eoliche si sarebbero impossessati di ampie zone, contribuendo ad una pericolosa involuzione dei sistemi naturali e alla perdita di risorse e di biodiversità.
Tuttavia, si registra una generale insoddisfazione tra i residenti nei Comuni del Parco. Ciononostante, dati alla mano, proprio l’istituzione del Parco ha garantito tantissimi investimenti e opportunità: i tanto temuti vincoli hanno, in verità, generato più reddito e benessere che limitazioni.
Si tratta pur sempre di un Parco abbastanza “giovane”: la seconda generazione di abitanti solo adesso inizia a misurarsi con questo patrimonio naturale. Vi è, poi, da dire che gli interessi localistici e settoriali delle varie gestioni politiche dello stesso, uniti ad una certa incapacità e incompetenza politica, hanno prodotto fallimenti e ritardi rispetto alle reali potenzialità del territorio.
Per capire chi ha ragione, prendiamo quale campione di riferimento un altro luogo, molto vicino al Parco nazionale, posto sul lato appenninico romagnolo, precisamente in provincia di Forlì-Cesena.
Il Monte Fumaiolo (sì proprio quello da cui nasce il Fiume Tevere!), in comune di Verghereto, che si era proposto di inserire nel nascente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per la vivace ostruzione degli amministratori locali e della popolazione residente è rimasto invece fuori dall’area protetta, isolato.
È un luogo (ora solo sito di Rete Natura 2000) con una ampissima ricchezza di biodiversità, tradizioni, storia e cultura, nonché di importanti aspetti paesaggistici legati a valori geologici unici. Insomma, con tutte le carte in regola per valorizzarlo e preservarlo come Parco. L’opposizione storica è generata da una chiusura tutta legata ad interessi venatori e selvicolturali, verso forme di protezione dell’ambiente naturale, riluttante a qualsiasi forma di collaborazione tra enti. Insomma siamo di fronte ad un ottimo territorio di confronto fra aree appenniniche vicine e uniformi sotto il punto di vista naturalistico, culturale e storico.
Il territorio del Monte Fumaiolo registra una diminuzione del numero dei cittadini residenti, dell’occupazione e delle presenze turistiche, in maniera più spiccata delle altre aree. I servizi al cittadino sono decisamente inappropriati, la popolazione sempre più vecchia e dalle pluriclassi nelle scuole si sta progressivamente avvicinando la chiusura di interi plessi. Pur mancando sistematici e metodologici monitoraggi ambientali e naturalistici, appare veloce la perdita di biodiversità, soprattutto per la scomparsa di specie target e per la frammentazione degli habitat, generata da eccessiva pressione antropica e sfruttamento delle risorse. A detta di chi amministra questi luoghi “Tutto viene gestito come sempre si è fatto…”.
Malgrado i tentativi “caserecci” di farsi spazio nel settore turistico, le infrastrutture dedite all’ospitalità appaiono inadeguate e versano, per lo più, in un generale stato di obsolescenza, con poca visibilità sul questo difficile mercato. Il marchio “Parco” avrebbe certamente garantito un certo successo nel settore del turismo ambientale.
Insomma, potremmo dire che nella diatriba “Parco” contro “non Parco”, finisce tre a uno!
Sono dati inoppugnabili, che devono spingerci verso una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente naturale, facendoci ancora una volta capire che per sottrarci dalla crisi economica, sociale, ambientale e sanitaria, occorre un modello di sviluppo che lasci da parte egoismo, malaffare, brama di potere e di ricchezza, pensando al bene comune e ai Parchi come custodi di questo patrimonio e vettori che ci lanciano verso il futuro.
(tratto da CASENTINO2000 | n. 322 | Settembre 2020)