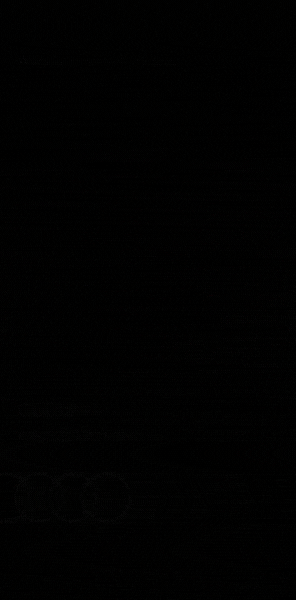di Antonella Oddone – La mononucleosi, o malattia del bacio, si trasmette con la saliva, quindi non solo con i baci profondi ma anche con lo scambio di bicchieri, posate, borracce, giochi che i bambini infetti possono mettere in bocca e scambiarsi. È una malattia endemica, cioè diffusa in tutto il mondo, ma con un’infettività più bassa rispetto a quella delle malattie trasmesse per via respiratoria come, per esempio, morbillo, influenza e covid. È causata da un virus a DNA appartenente alla famiglia degli herpes virus: il virus di Epstein Barr. Praticamente il 95% degli adulti è venuto a contatto con questo virus, spesso senza presentare sintomi evidenti. Soprattutto nei bambini molto piccoli infatti i sintomi possono essere lievi ed aspecifici.
Patogenesi. L’incubazione della malattia è molto lunga, da due a sette settimane: inizialmente il virus si replica nelle cellule epiteliali nasofaringee; quindi, diffondendo nelle diverse sedi dell’organismo, giunge nelle ghiandole salivari, nelle tonsille e adenoidi, successivamente nel sistema linforeticolare (linfociti B del sangue periferico) e, infine, nella milza e nel fegato. Infatti le cellule bersaglio sono proprio i linfociti B, quelli preposti alla difesa dell’organismo tramite la produzione di anticorpi. L’eliminazione de virus attraverso la saliva può durare settimane, mesi o addirittura anni (soprattutto nelle persone con basse difese immunitarie). Per questo motivo non è previsto isolamento: il bambino può tornare a scuola quando è clinicamente guarito, a giudizio del medico curante.
Sintomatologia. I sintomi sono molto vari: la mononucleosi classica, quella del bambino grandicello e dell’adolescente, si presenta con tonsille e adenoidi ingrossate e coperte da esteso essudato biancastro, spiccata ostruzione nasale, linfonodi molto ingrossati, soprattutto quelli angolo mandibolari e laterali del collo (ma spesso la linfoadenopatia è generalizzata). Anche la milza e il fegato sono interessati e diventano palpabili. È presente una grande stanchezza e il mal di gola con le difficoltà respiratorie sono spesso insopportabili. La febbre può essere alta, 39-40° gradi, o rimanere al livello di febbricola, ma è sempre di lunga durata: dai 5 ai 15 giorni e talvolta persiste anche per settimane! I bambini più piccoli hanno sintomi meno vistosi e in generale sopportano meglio sia il mal di gola che l’ostruzione nasale. Spesso c’è edema palpebrale e nel 5-10 % dei casi compare un esantema aspecifico. Gli studi che suggerivano la maggior frequenza di eruzioni cutanee dopo somministrazione di amoxicillina nei pazienti con mononucleosi sono datati, quelli più recenti smentiscono tale associazione, ma in ogni caso l’antibiotico è inutile, come in tutte le forme virali, ad eccezione dei rari casi in cui si sovrappone l’infezione da streptococco.
Diagnosi. Il sospetto viene nelle forme cliniche tipiche, soprattutto se accompagnate da febbre persistente, ma la certezza c’è con gli esami ematochimici, che mostrano un emocromo tipico, con un aumento consistente dei globuli bianchi, (riferito in particolare a linfociti e monociti che assumono una forma tipica e si chiamano “linfociti attivati”). Gli anticorpi specifici contro il virus di Epstein Barr aumentano velocemente: dopo una settimana si riscontrano gli anticorpi precoci (IgM) e iniziano a comparire quelli più tardivi (IgG). Se si riscontrano solo anticorpi della classe IgG vuol dire che la malattia è di vecchia data. Quasi sempre aumenta anche l’aminotransferasi epatica, segno che un interessamento del fegato è sempre presente anche quando non c’è epatomegalia.
Diagnosi differenziale. Si parla di sindrome mononucleosica perché sono molti gli agenti infettivi che danno quadri clinici simili. Per esempio l’adenovirus, il citomegalovirus, il toxoplasma, la tularemia, i virus epatitici, la rosolia, l’HIV.
Complicanze. La mononucleosi tende alla guarigione spontanea: la febbre in genere passa in 1-2 settimane, la linfoadenopatia in 3 settimane mentre può persistere a lungo il senso di prostrazione e la stanchezza. Da tenere presente la possibilità di sovra infezione da streptococco e la rottura della milza, che se ingrossata diventa più fragile. In questo caso, sarà bene evitare tutte quelle attività che comportino un rischio di traumi all’addome: per esempio sport di contatto (calcio, judo ecc.), sci, salti e tuffi, così come le passeggiate in bicicletta. Queste limitazioni cesseranno quando la milza sarà tornata alle sue normali dimensioni (di solito in 3-4 settimane).
Terapia. La terapia è di supporto: paracetamolo per la cefalea e i dolori associati alla febbre, buona idratazione, dieta leggera ricca di frutta e soprattutto riposo, che è il rimedio migliore per la stanchezza.
DOTT.SSA ANTONELLA ODDONE Medico pediatra
(Rubrica ESSERE L’Equilibrio tra Benessere, Salute e Società)