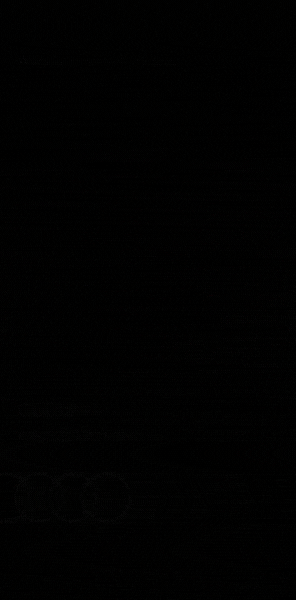di Mauro Meschini – Da molti mesi, dalla scadenza del mandato di Luca Santini, il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna non ha un presidente. Dovrebbe essere un tema su cui discutere e a cui prestare attenzione, ma non sembra che sia così escluso, naturalmente, le polemiche politiche tra comuni toscani e romagnoli o quelle tra le regioni e il ministero. Insomma come sempre si parla di tutto, ma forse senza prestare attenzione agli aspetti più importanti che dovrebbero essere legati alle competenze e conoscenze necessarie per ricoprire un ruolo così delicato.
Cinque anni fa, per la nomina di Santini, è stato evidentemente considerato un valore aggiunto anche il possesso della licenza di caccia, questa volta sarebbe forse auspicabile prendere come riferimento ben altro. Probabilmente anche da questa esigenza è cresciuta sempre più l’attenzione verso il nome di Fiorenzo Rossetti, laureato in Scienze Biologiche e con tanti anni di esperienza nella gestione e promozione del territorio e dell’ambiente. Attraverso questa nostra intervista abbiamo la possibilità di conoscerlo meglio e avere qualche idea su quello che ritiene importante e prioritario nella gestione dei parchi e per la gestione del Parco delle Foreste Casentinesi.
Rossetti può presentarci in sintesi il suo percorso formativo e professionale… «Sono nativo di Cesena e ho 49 anni. Ho quattro figli e da qualche tempo vivo nelle colline della media Valle del Savio. Ho conseguito una Laurea in Scienze Biologiche all’Università di Bologna e da quasi vent’anni lavoro nella Pubblica Amministrazione. Sono passato dal Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena all’Agenzia di Protezione Civile, per arrivare alla Regione Emilia-Romagna e all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, che gestisce le aree protette regionali della Romagna e i siti di Rete Natura 2000 e che tuttora mi ospita come Funzionario responsabile del Centro di Educazione Ambientale. Poi sono responsabile anche dell’attività di comunicazione e promozione del territorio, della gestione della sentieristica, della vigilanza, delle Guide del Parco e del volontariato ambientale, della progettazione europea e dei tirocini degli studenti provenienti da diverse Università Italiane. Conosco come le mie tasche ogni angolo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, che fin da piccolissimo ho frequentato assiduamente. Nelle mie attività lavorative ho realizzato innumerevoli progetti con L’Ente Parco che lo gestisce».
Il Parco è senza presidente ormai da molto tempo e di recente anche un’interrogazione parlamentare ha rilanciato la questione. Quali sono i principali motivi? «Il Parco è fermo e immobile dall’agosto scorso. Grazie all’interrogazione della Deputata Rossella Muroni, si è sottolineata la gravità e l’urgenza di chiarire questa situazione di mancanza di governance, che incide sull’operatività degli Enti Parco. Si attende, infatti, la nomina degli organi direttivi di 13 dei 24 Parchi nazionali italiani, Parco della Foreste Casentinesi incluso.
I motivi di questo “blocco” sono stati spiegati dal Ministro Sergio Costa ed è possibile comprendere la ragione del ritardo nella nomina del Presidente uscente (proposto dalla due Regioni competenti) Luca Santini, alla guida del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Cerco di sintetizzare.
1) Occorre un accordo sul nominativo tra Ministro e Presidenti delle due Regioni (che sembra, quindi non essere stato raggiunto);
2) Importante è la ricerca di una persona adatta, con curriculum di rilievo e non necessariamente appartenente al mondo politico;
3) La persona proposta deve avere una visione ambientale ben definita e illuminata sulla crescita sostenibile dei territori e sulla tutela dell’ambiente;
4) Le imminenti elezioni amministrative, non consentono di operare in un quadro politico definitivo».
Cosa significa per lei gestire e valorizzare un’area protetta? «Vi è una gestione conservativa, quella cioè che deve preservare il bene protetto. Facendo un parallelismo con un famoso museo o monumento, un Parco potrebbe essere accostato, come valore, al Colosseo; nessuno si sognerebbe di smontarlo o usarlo per farci una gara di motocross all’interno. In aggiunta, però, un Parco dona alla nostra civiltà dei benefici ambientali, legati alla salute e alla qualità della nostra stessa vita. Poi, è necessario in maniera intelligente e sostenibile, valorizzare questo inestimabile valore, di grande bellezza e unicità. Valorizzare un’area protetta, significa incuriosire e far sognare, quanti, vicini o lontani, vengono a contatto con il parco. Insomma, farli innamorare. È giusto non approfittare dei 60 milioni di presenze turistiche che ogni estate insistono sulla costa adriatica romagnola, per promuovere e valorizzare il Parco nazionale? Questo Parco fino ad ora è rimasto chiuso nei propri confini fisici, pur essendo un parco di valenza nazionale».
Quanto è importante il coinvolgimento dei cittadini nella gestione e nella progettazione di iniziative da realizzare nel e per un Parco? «Nel mio lavoro dedico tanto tempo al coinvolgimento dei cittadini e i migliori risultati in termini di prevenzione da illeciti ambientali, tutela e ripristino di beni ambientali, crescita culturale e dell’economia, si sono ottenuti tramite l’ascolto, sia che si trattasse di giovani cittadini col grembiule in un’aula scolastica, o di un pastore inferocito contro il lupo. Però ho anche compreso che ascoltare e coinvolgere non è sempre cosa facile e che, molte volte, sono gli stessi cittadini a dimostrarsi disinteressati. La comunicazione è parte del mio lavoro. Quella del coinvolgere è un’arte che ha per base il fornire giusti esempi, risultare attrattivi, comprensibili e non noiosi. Il sorriso e la passione poi sono il segreto per portare la voce delle persone nella vita di un Ente Parco».
Il territorio di un Parco può rappresentare anche una opportunità di sviluppo e lavoro per le comunità che vi risiedono? In che modo e in quali settori? «Il settore turistico in primis, ma ahimè occorrerà immediatamente avviare un percorso volto ad intercettare risorse economiche dirette a qualificare strutturalmente i vari complessi per l’accoglienza turistica, avvicinando i modelli che il turismo desidera. Questo svecchiamento delle strutture, unita alla grande competenza degli operatori turistici locali, potrà essere un’arma vincente, ma solo se si creerà una diffusa etica legata alla filiera corta dei prodotti e una economia perfettamente circolare. Quindi nasce la possibilità di crescita e sviluppo di attività lavorative legate a produzione agricola, allevamento, produzione e lavorazione del legno e artigianato. Completa il quadro, l’idea di aiutare la creazione di startup di tipo tradizionale, tecnologico e legato alle professioni di accompagnamento e guida. Ha mai compreso perché il sistema turistico regionale (e quindi la capacità di spesa) sia tutto rivolto a senso unico sulla costa?».
Tutela del Parco significa anche tutela e conoscenza degli animali che vi risiedono. Ma non sempre questo è semplice da realizzare… «Beh, ripeto, questo è il mio lavoro. L’educazione ambientale e alla sostenibilità, come più compitamente viene definita, è un ruolo molto importante dei parchi, che non devono solo trasmettere nozioni, come la differenza tra una salamandra e un tritone, ma devono andare ben oltre. Hanno la responsabilità di mostrare ai cittadini come funziona un ambiente sano e in equilibrio; devono trasmettere l’importanza di conservare la biodiversità ed essere di esempio».
Da più parti si sostiene la sua nomina alla presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi. Se questo accadesse quali sono le priorità su cui si concentrerebbe nei primi mesi? «Nella mia visione di “Parco”, c’è il ritorno al dialogo con la gente, per far sì che i cittadini possano riappropriarsi dei valori di un parco, mettendo al centro la ricerca di un equilibrio tra conservazione della biodiversità e sviluppo delle componenti sociali ed economiche, sconfiggendo gli ancestrali atteggiamenti di divisione tra paesi, comuni e regioni. Si tratta di Parco “Nazionale”: in quanto tale deve uscire dai propri, ristretti, confini, in un’ottica di cultura diffusa della montagna, vicinanza ai cittadini, collaborazione ampia con gli altri Enti e realtà territoriali anche di pianura, al fine di creare una rete condivisa di conoscenze ed esperienze, pianificazione e organizzazione dei servizi e ricerca di risorse economiche».
L’ultima domanda è legata alla possibilità di sviluppare gli impianti da sci del comprensorio Burraia-Fangacci. Secondo lei è un progetto realizzabile in grado di coniugare sviluppo e ambiente? «Per rispondere a questa delicata domanda faccio un esempio riferito al Parco Adamello Brenta, con cui ho collaborato e che ha tra i suoi compiti la tutela dell’orso. Il suo territorio ha come fulcro il carosello sciistico di Madonna di Campiglio. Sa come viene vista quella zona sciistica dai ricercatori del Parco, che si affannano a conservare la fauna selvatica e a coniugare lo sviluppo economico legato al turismo? Come un grande concentratore di presenze turistiche, che proprio in quella fascia sciistica si dirigono, lasciando quanto più indisturbato il rimanente territorio. Questo non vuol dire che sia giusto tagliare tutta la montagna di Monte Falco per farci piste da sci, ma occorre vedere quel luogo alla stessa maniera e ammettere che lo sci possa essere un modo per attrarre e avvicinare alla montagna nel modo corretto, se fatto con intelligenza, tante persone».