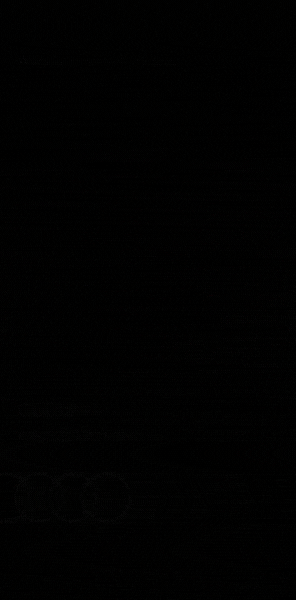di Marco Roselli – In questo primo articolo parleremo della vite e del vino dal punto di vista storico mentre nel prossimo affronteremo le questioni pratiche per la coltivazione e la vinificazione in Casentino.
La vite, una pianta immortale
Nessuna specie vegetale o derivato dalla trasformazione agricola, presenta una diversificazione produttiva o qualitativa paragonabile a quella che offre la vite nelle sue circa 10.000 varietà o gli infiniti profili sensoriali dei vini, che da questa vengono prodotti in tutte le parti del mondo. Questa diversità non dipende solo dalle condizioni pedoclimatiche dei luoghi dove l’uva viene prodotta, ma è soprattutto il risultato del lavoro di numerose generazioni di viticoltori che negli angoli più disparati dell’Europa e del vicino oriente, a partire dal Neolitico, hanno dato a questa bevanda una precisa identità culturale, espressione di un interscambio continuo tra uomo, vitigno e ambiente di coltivazione.
La vite è presente nel pianeta terra da milioni di anni, così come testimoniano i ritrovamenti di semi fossili e impronte di foglie, risalenti all’epoca della deriva dei continenti. Da quel fenomeno geologico si originarono i gruppi di vite delle specie americane, euroasiatiche e asiatiche, dalle quali sono emerse le varietà coltivate che conosciamo.
Storia della vite e del vino nel bacino del Mediterraneo
L’agricoltura ha avuto inizio nel Neolitico a partire dai villaggi preistorici dove il grande accumulo di radici, semi, erbe, piante arboree tra cui la vite, davano origine ai primi frutteti caotici dai quali l’uomo, successivamente, scelse quelli migliori e più produttivi.
L’evoluzione delle prime forme di viticoltura può essere così sintetizzata: nelle forme più primitive l’uomo si cibava delle bacche di vite che incontrava; quindi gli embrionali viticoltori si dedicarono alla protezione delle viti più produttive nei boschi, in areali di proto domesticazione. Per un tempo lunghissimo la selezione delle viti selvatiche non comportò miglioramenti sensibili. Solo 5.000 anni prima di Cristo nel vicino Oriente e 11.000 anni a. C. in Grecia, appaiono le testimonianze paleobotaniche (la forma dei vinaccioli) che fanno intravedere le caratteristiche della vite domestica.
Nel 1988 l’università della Pennsylvania, effettuando analisi molto sofisticate in un’anfora rinvenuta a Godin Tepe, un villaggio dell’Iran occidentale, rintracciò la presenza di acido tartarico e di una resina avente funzione di conservante nei confronti dell’acescenza, analogamente a quanto facevano e ancora fanno i greci con la resina del Pino d’Aleppo per produrre il vino Retsina.
La datazione al C – 14 dell’acido tartarico nei reperti rivelò che l’età di quel residuo era di circa 5.000 anni.
Da allora in avanti comincia la storia della vite e del vino che nel bacino del mediterraneo attraverserà tutte le grandi civiltà, da quella mesopotamica a quella egizia (nel corredo funebre di Tutankamon erano incluse delle anfore contenenti vino con riportato la zona di provenienza, l’annata, il produttore) passando per i greci (il mito di Dioniso; il simposio, dove il vino non doveva mai essere bevuto da soli). Poi la vite giunse agli etruschi ai quali si devono il miglioramento delle tecniche di coltivazione e vinificazione (dalla toscana esportarono viti e tecniche in tutta l’Italia del Nord, tra cui l’alberata) fino a giungere ai romani che portarono la vite ovunque poterono nelle provincie imperiali (il convivio romano era l’equivalente del simposio greco) non mancando di descrivere le tecniche vitivinicole nelle opere dei grandi autori [ad esempio, Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia dedica interi capitoli alla vite, descrivendone la potatura, le malattie, la qualità dei vitigni. Varrone (I sec. a. C.) descrivendo l’area di Mediolanum dice che le viti, appoggiandosi ad alberi chiamati opuli, facevano passare i tralci da un albero all’altro e Columella (de Re rustica – Liber de arboribus) accenna agli alberi preferiti: opulus (acero campestre), olmo, frassino, fico e olivo a sud del Po, e anche corniolo, tiglio, carpino e quercia a nord]. Alla fine dell’impero romano il clima mutò radicalmente, e così come era avvenuto per l’olivo anche la vite coltivata conobbe un arretramento limitandosi alle zone più favorevoli. Di conseguenza anche il vino restò appannaggio solo dei signori che potevano permetterselo.
La vite nel Casentino in epoca medievale. Una breve sintesi
Facendo un salto in avanti di diversi secoli, a titolo di esempio, appare utile citare l’ampio lavoro documentale del professor Alberto Fatucchi pubblicato nel testo “La ripresa demica e agricola di una valle casentinese dopo il mille – Accademia dei Gergofili”. La trattazione riguarda la valle dell’Archiano e attinge a numerosissime opere oltre a studi propri.
In questa si legge come la più ricordata e più diffusa tra le coltivazioni arboree è quella della vite, fino all’altitudine di 700 metri. Non si parla mai di “terra vineata” cioè di coltura promiscua, ma di “vinea”, e talvolta di “terra cum vinea”. La prima espressione è da intendere certamente come vigneto specializzato. Ma la vinificazione in grandi quantità è attestata già in età romana presso Soci. Lo richiedeva anche l’economia di consumi locali… E ancora: “La vigna era una coltura così pregiata che lo stesso vescovo Elemperto (986-1010) ne aveva fatta piantare una a Montefatucchio, nella valle dell’alto Corsalone. Se ne parla nel 1008 ed è ricordata ancora nel 1065. Non se ne sarebbe parlato così specificatamente se non fosse stato un impianto specializzato.
Verso il Rinascimento
E’ nota a tutti la citazione dell’avvocato Carlo Beni nella Guida Illustrata del Casentino. Al capitolo “cultura e prodotti” riporta: “Tutta la parte inferiore della valle ha la coltivazione comune nella Toscana, ed è rinomata per l’eccellenza dei suoi prodotti (1). La vite si coltiva con frutto anche ad altezze considerevoli”.
(1) In una lettera scritta dal Magnifico Lorenzo al marchese Pietro Alamanni ambasciatore a Roma nel 1491, si rammenta il vino del Casentino, che come cosa prelibata si mandava in regalo: “tre dì sono vi mandai due some di vino di quelle sorte di Casentino, et dovranno essere costì presto, perché questi tempi sono a proposito et freschi; desidero che si conduchino in modo, che rieschino come sono qui alla botte, che parecchi anni fa non ci furono i migliori”.
Una parassita minaccia la viticoltura mondiale. La fillossera della vite
La Fillossera è un insetto di origine americana arrivato in Europa intorno al 1860. Il parassita giuse in Francia per poi diffondersi rapidamente in tutte le zone viticole, provocando danni ingentissimi che fecero temere la scomparsa della coltura. In Italia la fillossera (nella parte inferiore della foto sotto i danni della fillossera sulle foglie) fu riconosciuta ufficialmente nel 1879, riscontrata in vigneti presso Lecco e Agrate e dopo un solo anno era già arrivata in Sicilia. Le viti presenti in Europa venivano attaccate all’apparato radicale disorganizzandone i tessuti, mentre le foglie risultavano meno sensibili. Solo grazie al lavoro congiunto di entomologi, botanici, tecnici di diverse nazioni e alla scoperta che quelle americane mostravano radici resistenti alle punture dell’insetto si riuscì a debellarlo. Tuttavia ci vollero decenni per ricostruire la viticoltura. Questo fu possibile inserendo il piede americano tramite innesto.
Viticoltura in Casentino nel secondo dopoguerra
Nel Casentino agricolo post bellico il vino rappresentava per lo più un alimento. Le fatiche dei contadini venivano sopportate anche con una bevanda che poteva alternare annate buone ad annate sfavorevoli, con uve scadenti già prima della vendemmia. Da ciò è anche derivato un modo tutto casentinese di esprimere la gradevolezza di un vino: “bisogna essere almeno in quattro per berlo; due lo tengono e uno lo fa bere”. L’importante era dunque la quantità di uva con meno attenzione alla qualità dei vini ottenuti.
A questa condizione contribuivano vitigni e portainnesti che allungavano il periodo di maturazione protraendolo nel tardo autunno, una stagione che fino a qualche decennio fa, nella nostra valle, iniziava già a fine agosto con piogge copiose e persistenti.
Oggi il Casentino ospita diversi esempi di viticoltura moderna con ottimi vini che nulla hanno da invidiare a quelli di altre vallate. Se ne parlerà nel prossimo articolo.
(Fine prima parte)
“Giungemmo alla terra dei Ciclopi, prepotenti e selvaggi. Essi lasciano fare agli dei: non piantano un albero con le loro mani, non arano. Ma senza semine e senza colture tutto là viene su, il frumento e l’orzo, e viti che portano grappoli enormi, da vino: glieli ingrossa così la pioggia di Zeus…” “Allora io mi feci avanti. Andai vicino al Ciclope, gli parlavo, tenendo fra le mani una ciotola colma di vino nero. Dicevo: ‘Ciclope, to’, bevi vino ora che hai mangiato carni d’uomo. Così saprai che sorta di bevanda è questa che la nave nostra teneva in serbo…” (Odissea di Omero)
Bibliografia
– La vite e il vino, AA.VV. Collana Coltura e Cultura Viticoltura moderna, G. Dalmasso, Hoepli
– Fitopatologia ed entomologia agraria Ferrari – Marcon – Menta, Edagricole
– Guida illustrata del Casentino, Avv. Carlo Beni, Brami Edizioni, Bibbiena
(tratto da CASENTINO2000 | n. 317 | Aprile 2020)